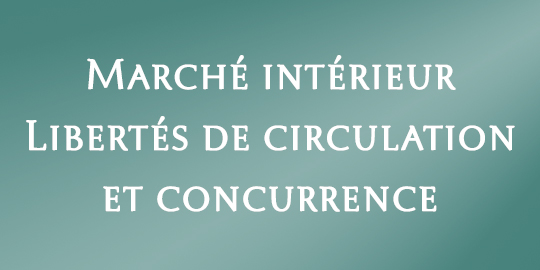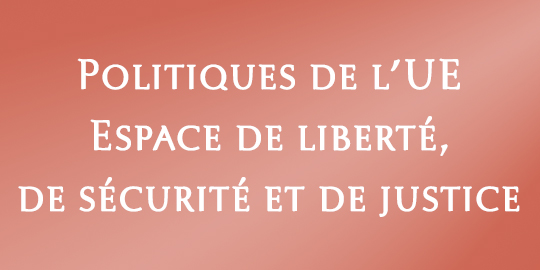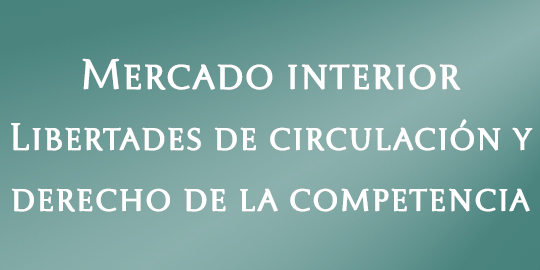- 3159 views
Keywords: non-discrimination – religious symbols – Islamic veil – labour relations – directive 2000/78/EC – discrimination grounded on religion or belief.
Nella causa Achbita,[1] la Grande Chambre della Corte di giustizia ha emanato una sentenza che ha suscitato l’attenzione della stampa, che l’ha così riassunta: se un’impresa privata licenzia una dipendente musulmana perché indossa il velo, non viene leso il divieto di discriminazione. Sono subito divampati commenti entusiastici o scandalizzati, ma forse bisogna leggere con attenzione ciò che la Corte di giustizia ha effettivamente scritto.
Si tratta di una decisione molto equilibrata, che accoglie l’impostazione dell’Avvocato generale Kokott, nelle sue articolate Conclusioni,[2] in cui trapela la preoccupazione per gli effetti che la decisione della Corte potrà esprimere in relazione a casi futuri, a partire dalla causa Bougnaoui e ADDH,[3] proveniente dalla Francia e ancora pendente al momento della presentazione delle Conclusioni e decisa nello stesso giorno della sentenza Achbita.
La sentenza distingue tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta, seguendo quanto previsto dalla direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.[4]
Spiega la Corte che si ha discriminazione diretta,[5] quando una persona è trattata meno favorevolmente rispetto agli altri a causa delle sue convinzioni politiche, religiose, le inclinazioni sessuali, gli handicap ecc. Ciò non si verifica in questo caso, poiché la ditta, che fornisce servizi di sorveglianza e sicurezza, nonché servizi di accoglienza a diversi clienti del settore sia pubblico che privato, ha una norma del regolamento aziendale che vieta ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose. È quindi una regola generale, non rivolta in particolare alla dipendente in questione o ai simboli che essa vuole indossare. Per anni la dipendente si era presentata senza indossare il velo, e quando ha iniziato a farlo conosceva perfettamente l’esistenza di questa regola aziendale: si trattava di una regola non scritta che vigeva da tempo, trascritta poi in un regolamento aziendale solo dopo che la dipendente aveva comunicato l’intenzione di indossare il velo. La conclusione a cui arriva la Corte, sulla base degli elementi del fascicolo, è che non risulta che l’applicazione della norma aziendale alla dipendente musulmana “sia stata diversa dall’applicazione della medesima norma a qualsiasi altro dipendente”.[6]
La Cassazione belga aveva sollevato la questione pregiudiziale solo sotto il profilo della violazione del principio di discriminazione diretta. Ma la Corte di giustizia ritiene opportuno integrare la questione, considerando anche l’ipotesi che nel caso di specie si possa configurare una discriminazione indiretta,[7] anticipando così una conclusione a cui potrebbe giungere il giudice del rinvio. Discriminazione indiretta – spiega ancora la Corte – si verifica quando una norma o una prassi apparentemente neutri possono di fatto porre in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia: sempreché tale regola non sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Spetta però al giudice di rinvio valutare la situazione di fatto e cogliere quindi gli eventuali indizi di una discriminazione indiretta. Ma alla Corte di giustizia preme tracciare comunque le linee generali entro le quali devono svolgersi le valutazioni del giudice nazionale, in modo da costruire il precedente per le decisioni future in materia. In questa prospettiva, la Corte chiarisce che “la volontà di mostrare, nei rapporti con i clienti sia pubblici che privati, una politica di neutralità politica, filosofica o religiosa, deve essere considerata legittima”;[8] vietare simboli identitari è un criterio “idoneo ad assicurare la corretta applicazione di una politica di neutralità, a condizione che tale politica sia realmente perseguita in modo coerente e sistematico”;[9] infine il divieto può essere considerato necessario se interessi unicamente i dipendenti che hanno rapporti diretti e “visivi” con i clienti.[10]
Questa è un’apertura importante per la ricorrente. La dipendente svolgeva funzioni di receptionist, per cui a contatto “visivo” con il pubblico con i limiti e i condizionamenti che ciò può comportare per l’immagine aziendale; spetta al giudice di merito “verificare se, tenendo conto dei vincoli inerenti all’impresa, e senza che quest’ultima dovesse sostenere un onere aggiuntivo”,[11] sarebbe stato possibile proporle un posto di lavoro che non comportasse un contatto visivo con il pubblico, invece di procedere al suo licenziamento.
In conclusione, “spetta al giudice del rinvio, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, tenere conto degli interessi in gioco e limitare allo stretto necessario le restrizioni alle libertà in questione”.[12] Per cui non è affatto detto che per la signora Samira Achbita la partita sia definitivamente persa.
Lo stesso giorno della sentenza Achbita, la Grande Chambre ha dovuto occuparsi una seconda volta del velo islamico e della discriminazione che ne può derivare per i lavoratori. Nella sentenza Bougnaoui,[13] la Corte affronta il caso di una donna islamica licenziata perché si rifiutava di togliere il velo islamico quando svolgeva la propria attività lavorativa presso clienti dell’impresa di cui era dipendente. Era stata assunta come ingegnere progettista e anche al momento dell’assunzione indossava il velo: il problema sorge però quando un cliente dell’impresa, presso cui l’ingegnere era stata inviata, si lamenta che il velo “aveva infastidito alcuni suoi collaboratori”.[14] Che questo potesse accadere era un’ipotesi prevista al momento dell’assunzione, per cui l’impresa aveva avvertito la nuova assunta che avrebbe dovuto rinunciare al velo in certe circostanze, quando i clienti lo avessero richiesto.
La Corte di giustizia ritiene che il licenziamento sia discriminatorio, perché “la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non può essere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi di detta disposizione”.[15] Tutta l’argomentazione della Corte ruota attorno a questo interrogativo: la “neutralità” imposta al dipendente e al suo abbigliamento costituisce un “requisito essenziale e determinante” per lo svolgimento del lavoro? Mentre nel caso Achbita la risposta era affermativa, nel caso Bougnaoui è negativa. La differenza sta in questo elemento determinante: che la signora Achbita era una receptionist che per il suo ruolo costituiva il contatto visivo e di primo approccio del cliente alla impresa di servizi, di cui concorreva perciò a formare l’immagine esterna; mentre l’ingegnere Bougnaoui era una tecnica progettista inviata a svolgere la sua attività presso un cliente che si era rivolto all’impresa per ricevere le prestazioni che tale impresa era capace di erogare, rispetto alle quali che il tecnico inviato indossi o meno il velo islamico non può incidere in alcun modo, né sull’immagine della ditta né sulla qualità del servizio erogato dal tecnico. Il licenziamento quindi è conseguenza soltanto di atteggiamenti discriminatori del cliente, anzi di alcuni suoi collaboratori.
Può essere utile ricordare un lontano precedente davanti alla Corte costituzionale. Si trattava della dipendente di una ditta di vigilanza licenziata perché i clienti non gradivano che fosse una donna a garantire il servizio di guardia giurata.[16] La Corte allora affermò un principio semplice e chiaro: il divieto di discriminazione opera sul piano generale, e quindi anche nei rapporti contrattuali tra privati. Ma non c’è dubbio che, rispetto alla discriminazione in base al sesso, quelle basate sulla religione e i suoi simboli sembrano trovare maggiori margini di giustificazione nella pretesa di “neutralità” che l’attività lavorativa del dipendente deve preservare. Sono margini esigui, però, che in fondo si ancorano esclusivamente al sentimento, e ai pregiudizi, del cliente.
Perché il costo di questi pregiudizi debba assumerselo il lavoratore e non il datore di lavoro è una domanda legittima, a cui forse si dovrebbe rispondere prendendo in attenta considerazione le condizioni di fatto e le circostanze concrete. Che è esattamente quello che la Corte di giustizia invita i giudici nazionali a fare.
--------------------
European Papers, Vol. 2, 2017, No 1, European Forum, Highlight of 5 April 2017, pp. 457-460
ISSN 2499-8249 - doi: 10.15166/2499-8249/129
* Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara, bnb@unife.it.
[1] Corte di giustizia, sentenza del 14 marzo 2017, causa C-157/15, Achbita [GS].
[2] Conclusioni dell’A.G. Kokott del 31 maggio 2016, causa C-157/15, Achbita.
[3] Corte di giustizia, sentenza del 14 marzo 2017, causa C-188/15, Bougnaoui e ADDH [GS].
[4] Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
[5] Art. 2, par. 2, lett. a), direttiva 2000/78/CE.
[6] Achbita [GS], cit., par. 31.
[7] Art. 2, par. 2, lett. b), direttiva 2000/78/CE.
[8] Achbita [GS], cit., par. 37.
[9] Ivi, par. 40.
[10] Ivi, par. 42.
[11] Ivi, par. 43.
[12] Ibidem.
[13] Bougnaoui e ADDH [GS], cit.
[14] Ivi, par. 14.
[15] Ivi, par. 34.
[16] Corte costituzionale italiana, sentenza del 16 gennaio 1987, n. 17.